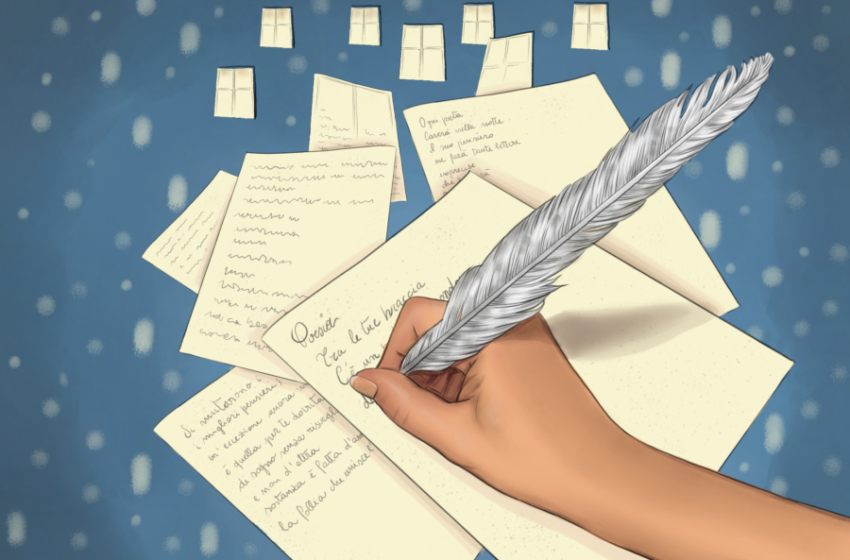
A cura di Raffaele Nigro.
La raccolta di esordio, Lembi di sodaglia, con cui Francesco Bellino salutava il mondo della letteratura con una aperta adesione a una poesia lirica e dialogica vicina al frammento greco e alla scrittura dei grandi meridionali, Bodini, Scotellaro, Sinisgalli,Gatto,si ripropone oggi a mezzo secolo di distanza.
Il mondo contadino della Capitanata era allora al centro della sua ispirazione, insieme agli affetti familiari e all’elogio della semplicità. E tale si ripresenta in questa raccolta, dove fanno irruzione nomi e temi di quella losoa
dell’umano che Bellino ha perseguito nel suo sistema di pensiero, accostandosi a Wittgenstein, Popper, Gadamer, ai grandi temi posti dalla filosofia dell’umanesimo integrale, Maritain, e del personalismo comunitario, Mounier.
Il soggetto di questi versi è la morte, la consunzione dei corpi, insieme alla pietà per quanti hanno trovato sepoltura nella piana della Daunia, ovvero le terre dei 5 Reali Siti, il mondo di Orta Nova che Francesco ha conosciuto negli anni dell’infanzia e della giovinezza, prima che partisse per gli studi universitari e per il mondo che lo ha accolto e laureato filosofo della formazione, e poeta contrapposto a un tempo di esasperata
ricerca dell’economia come fondamento e di scarsa nezza nei rapporti umani.
Con un interrogativo retorico che chiama alla memoria l’apertura di Spoon River anthology e la reinterpretazione di De Andrè, si presenta la raccolta di versi in cui ci addentriamo, così densa di pathos e di malinconia. Con un viaggio inverso, dalla sommità della collina dov’erano sepolti i morti di Lee Masters alla pianura, innita come il volto del presente continuo qual è la vita. Dove sono niti i grandi che hanno abitato e attraversato la pianura? Dove sono Diomede e Dauno, fondatori di tanti villaggi, dove i cortei di Federico II di Svevia, le torme di
crociati che scendevano a Brindisi per imbarcarsi alla volta di Gerusalemme? E dove hanno concluso la loro vicenda esistenziale le tante gure più vicine a noi nel tempo, Pietro Giannone, Umberto Giordano, Giuseppe Di Vittorio? E con loro creature della cronaca quotidiana, sparite come grani di sabbia nel vento dei secoli, montagne di ossa che hanno costruito gli attimi fuggevoli e anonimi dei giorni e delle notti, contadini, mamme, prostitute, bidelli, farmacisti, sindaci.
“Quanta erba è cresciuta sotto i cipressi / La tortora è morta / di crepacuore, / l’usignolo ha perso / la sua compagna / e il vento piega le pratoline”. Tutti giacciono sotto le zolle e solo le anime non sono state toccate dalla morte,ma volate in cielo si presenteranno a noi sotto altre forme. Il racconto elegiaco si presenta al lettore ora in terza persona ora in prima, a seconda che racconti il poeta o che gli si sostituisca qualcuna delle tante creature che “in terra e in mar semina morte” direbbe Foscolo.
La voce del poeta, prestata talora alle gure evocate, come vox clamans in deserto, nel deserto della vita, si consuma a passi lenti nella pianura. Dove vita e pianura sono tutt’uno. E dove le generazioni si consumano
non sempre lasciando traccia di sé. Ecco allora Federico II che ricorda la predizione secondo cui sarebbe morto in
località segnata da un ore, ovvero a Castelorentino; Alfonso I d’Aragona venuto a instaurare la dogana delle pecore a San Severo, lui che ordina di convogliare tutti gli animali da pascolo in transumanza no alla Regia Dogana. È la grande storia, quella alta che domina la vita di re e principi ma anche degli uomini semplici. È la storia dei miti che abitano la terra daunia, l’amore di Cristalda e di Pizzomunno, l’agiografia qui esposta in
modo delirante, dell’Arcangelo che viene sul Gargano a combattere il diavolo, lo Scazzamauriello che sbuca dalle crepe della terra e gioca con le partorienti.
E poi la cronaca quotidiana, la vita che scivola ininterrotta e tocca la sorte di Maria Grazia, bracciante agricola e moglie e madre paziente, di Marietta la visionaria, quella dei contadini senza terra che imbracciano armi contro i potenti, senza tetto sepolti negli ossari comuni, donna Carolina, maestra di una innità di ragazzi. Tanti, tutti, che “dormono dormono sulla pianura”. E insieme a costoro i popoli in transumanza passati nei secoli dall’Illiria alle
coste di Mattinata e di Manfredonia, gli eroi sbarcati dal Peloponneso, la soldataglia venuta dalla Spagna o dalla Francia. Tutti tacciono sotto terra e solo canta il vento della pianura. Basta appoggiare l’orecchio al suolo, scriveva Nicola in Sole nell’Ode allo Jonio, per ascoltare l’eco dei passi e dei cavalli. Scendete nelle grotte di Siponto, scriveva Cristanziano Serricchio, cercate tra i banchi degli scavi archeologici e leggete ciò che riportano le stele daunie, per riavere sentore di mondi perduti, di vite che si sono consumate. È così che sono trapassate
le civiltà di Salapia, di Herdonia, di Arpi.
Tutto viene dal mistero e va verso il mistero, avvolto spesso dal rumore delle armi, confuso nell’odio e nella violenza, nella sofferenza dei popoli. Chi potrà sentire l’infelicità di donna Luigietta impazzita per i gli emigrati in Argentina e mai tornati? Chi ricorda i giovani, morti sui fronti di guerra per offrire alle generazioni future una vita migliore? In un richiamo diretto a Sinisgalli il poeta dice: “Tornerò tra 10 trilioni di anni tra cherubini e serani”. Non senza aver spiegato che è stato “migrante per tutta la vita”. Anche lui, ridotto in polvere, tornerà a giacere nel fango della pianura. Perché il senso della vita sta in ciò che la pianura sa operare, la trasformazione delle ossa in concime e poi in erbe e ori, che a loro volta si trasformeranno in materia che si rinnova e rinnova la vita.
Perché ciò che muta nel mondo è solo la forma dei corpi. I prestiti di Bellino sono molteplici, oltre ai poeti che abbiamo citato, tornano nei solchi dei suoi versi Alfeo di Mitilene, Baudelaire, Foscolo, i grandi temi del decadentismo europeo e insieme, i canti religiosi del Mese mariano intonati dalle Figlie di Maria e da molti di noi, nella nostra infanzia, “O Maria quanto sei bella”, “Dell’aurora tu sorgi più bella”. Questi canti introducono a un altro aspetto della poesia di Bellino, la religiosità, la fede in Dio, nella Vergine e in Cristo.
Una fede che si scontra con una consapevolezza tragica e razionale, disseminata tra i versi, un tremor pulveris
et nis, un potente richiamo alla tragicità dell’esistenza e della morte, ribadito in esergo nella raccolta, come a chiusura del pianto e della vita: “Qui termina il mio cammino/non c’è traccia né impronta, tutto è polvere”.
 Skip to content
Skip to content
